– Nuove uscite –
Saggistica: Il mito infranto di Antonio Galdo
Dal 22 gennaio in libreria e in e-book il primo libro Codice del 2025, Il mito infranto di Antonio Galdo.
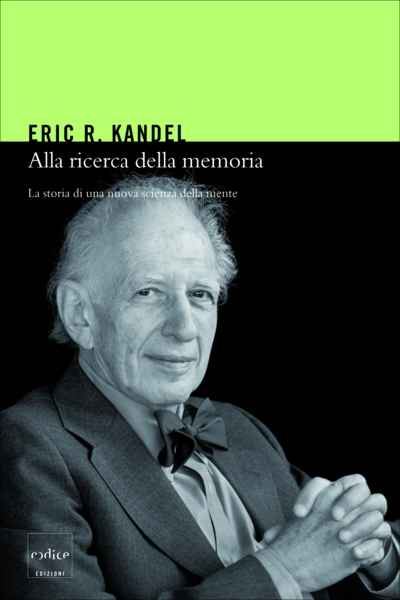
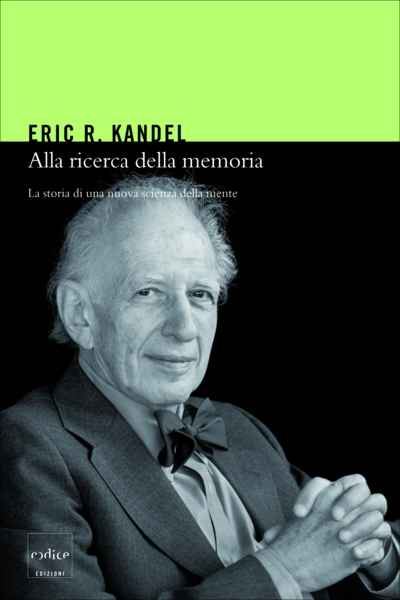 «In che modo il terrore provato da un bambino nel sentire i colpi dei nazisti alla porta di casa, la vigilia della Notte dei cristalli, si è impresso come una cicatrice nel tessuto molecolare e cellulare del cervello, con una forza tale da consentirgli di rivivere quell’esperienza a decenni di distanza?»
«In che modo il terrore provato da un bambino nel sentire i colpi dei nazisti alla porta di casa, la vigilia della Notte dei cristalli, si è impresso come una cicatrice nel tessuto molecolare e cellulare del cervello, con una forza tale da consentirgli di rivivere quell’esperienza a decenni di distanza?»
Vi regaliamo un estratto da Alla ricerca della memoria di Eric R. Kandel, premio Nobel per la medicina e professore alla Columbia University.
Non è il passato in quanto tale che ci governa, eccetto, forse, in senso biologico. Sono le immagini del passato, spesso fortemente strutturate e selettive come miti. Immagini e costruzioni simboliche del passato sono impresse, qua- si alla stregua di informazioni genetiche, sulla nostra sensibilità. Ogni nuova era storica rispecchia se stessa nella raffigurazione e nella mitologia attiva del proprio passato.
La memoria mi ha sempre affascinato. Pensateci – tutti possiamo richiamare alla mente il primo giorno di liceo, il primo appuntamento, il primo amore. Nel farlo, non ci limitiamo a rievocare l’evento, ma riviviamo l’atmosfera in cui si è svolto: le visioni, i suoni, gli odori, il contesto sociale, l’ora del giorno, le conversazioni, le sfumature emotive. Ricordare il passato è una forma di viaggio mentale nel tempo, che ci svincola dalle costrizioni di spazio e tempo e ci consente di muoverci liberamente in dimensioni del tutto diverse. Il viaggio mentale nel tempo mi permette di staccarmi dalla scrittura di questa frase nel mio studio di casa, affacciato sul fiume Hudson, e di proiettarmi all’indietro di 67 anni e verso est, oltre l’oceano Atlantico fino all’Austria, a Vienna, dove sono nato e dove i miei genitori possedevano un piccolo negozio di giocattoli.
È il 7 novembre 1938, il giorno del mio nono compleanno. I miei genitori mi hanno appena dato il regalo che desideravo ardentemente: un modellino di automobile a batteria telecomandato. È una bellissima, sfolgorante macchina blu, con un lungo cavo che collega il motore a un volante per mezzo del quale io posso controllare i movimenti della vettura, il suo destino. Per i due giorni successivi guido l’automobile in lungo e in largo nel nostro piccolo appartamento – attraverso il soggiorno, in sala da pranzo, sotto le gambe del tavolo, dove i miei genitori, il mio fratello maggiore e io ceniamo tutte le sere, dentro e fuori la camera da letto – sterzando con immenso divertimento e crescente sicurezza. Ma il mio piacere ha vita breve. Due giorni dopo, nelle prime ore della sera, un violento bussare alla porta di casa ci fa trasalire. Ricordo quei colpi ancora oggi. Mio padre non era ancora rientrato dal lavoro in negozio. Mia madre apre la porta. Entrano due uomini. Si presentano come poliziotti nazisti e ci ordinano di prendere con noi l’essenziale e di lasciare l’appartamento. Ci danno un indirizzo e ci dicono che saremo alloggiati là fino a nuovo ordine. Mia madre e io impacchettiamo solo un cambio d’abiti e il necessario da toeletta, ma mio fratello, Ludwig, ha il buon senso di prendere con sé i due suoi averi per lui di massimo valore: la collezione di francobolli e quella di monete. Con le nostre poche cose, camminiamo per parecchi isolati fino alla casa di una coppia di anziani ebrei benestanti che non abbiamo mai visto prima.
Il loro appartamento spazioso e ben ammobiliato ai miei occhi sembra molto elegante, e l’uomo che vi abita fa su di me una forte impressione. Quando va a letto indossa una camicia da notte riccamente ornata, molto diversa dal pigiama di mio padre, e dorme con una berretta da notte per proteggere i capelli e con una reticella sul labbro superiore per mantenere in posizione i baffi. Anche se abbiamo invaso la loro privacy, i nostri ospiti designati sono premurosi e gentili. Malgrado la loro agiatezza, sono piuttosto inquieti e spaventati per gli eventi che ci hanno portati presso di loro. Mia madre è in imbarazzo per questa ospitalità forzata, rendendosi conto che i due sono probabilmente altrettanto a disagio con tre sconosciuti piombati tra di loro all’improvviso. Nei giorni che trascorriamo nell’appartamento di questa coppia, sistemato con tanta cura, io sono disorientato e intimorito. Ma per noi tre la più grande fonte di apprensione non è il ritrovarci in casa di estranei, quanto invece la sorte di mio padre: è scomparso e non abbiamo idea di dove sia. Dopo svariati giorni ci viene finalmente consentito di fare ritorno a casa. Ma l’appartamento che troviamo non è lo stesso che abbiamo lasciato. È stato rovistato da cima a fondo e ogni cosa di valore è stata portata via: la pelliccia di mia madre, i suoi gioielli, l’argenteria da tavola, le tovaglie di pizzo, alcuni degli abiti di mio padre, e tutti i miei regali di compleanno, compresa la bellissima, sfolgorante automobile blu telecomandata. Con nostro enorme sollievo, comunque, il 19 novembre, alcuni giorni dopo il nostro ritorno nell’appartamento, vediamo tornare mio padre. Ci dice di essere stato arrestato insieme a centinaia di altri ebrei, e rinchiuso in una caserma dell’esercito. Ha ottenuto di venire rilasciato avendo potuto dimostrare di aver prestato servizio militare nell’esercito austroungherese, combattendo a fianco della Germania durante la Prima guerra mondiale.
I ricordi di quei giorni – guidare l’automobile per tutta la casa con crescente sicurezza, sentire i colpi alla porta, ricevere dai nazisti l’ordine di andare in un appartamento di sconosciuti, ritrovarci derubati dei nostri averi, la scomparsa e la riapparizione di mio padre – sono i ricordi più potenti della fase iniziale della mia vita. In seguito avrei appreso che quegli eventi erano accaduti in concomitanza con la Notte dei cristalli, quella notte sciagurata che ha mandato in frantumi non solo le finestre delle nostre sinagoghe e del negozio dei miei genitori, ma anche le vite di innumerevoli ebrei in tutta l’area di lingua tedesca. Guardando in retrospettiva, la mia famiglia è stata fortunata. La nostra sofferenza è stata risibile in confronto a quella di milioni di ebrei che non hanno avuto altra scelta se non quella di rimanere nell’Europa in mano ai nazisti. Dopo un anno di umiliazioni e di timori, Ludwig, allora quattordicenne, e io riuscimmo a lasciare Vienna diretti negli Stati Uniti, per andare a vivere dai nonni a New York, dove i nostri genitori ci avrebbero raggiunti sei mesi più tardi. Anche se la mia famiglia e io abbiamo vissuto sotto il regime nazista soltanto per un anno, lo smarrimento, la miseria, l’umiliazione e la paura che ho sperimentato in quell’ultimo anno a Vienna lo hanno reso un periodo determinante della mia vita.
È difficile far risalire la complessità degli interessi e delle azioni della vita di un adulto a specifiche esperienze dell’infanzia e della giovinezza. Eppure non posso fare a meno di collegare al mio ultimo anno a Vienna il mio successivo interesse per la mente: per il modo in cui le persone si comportano, l’imprevedibilità delle motivazioni e il persistere della memoria. Dopo l’Olocausto, uno dei moniti degli ebrei è stato “Non dimenticare mai”, un’esortazione alle generazioni future per rimanere vigili contro l’antisemitismo, il razzismo e l’odio, le disposizioni mentali che hanno reso possibile il verificarsi delle atrocità naziste. Il mio lavoro scientifico indaga le basi biologiche di quel motto: i processi del cervello che ci mettono in grado di ricordare. Le mie reminiscenze di quell’anno a Vienna hanno trovato per la prima volta espressione ancora prima che maturassi interesse verso la scienza, quando studiavo al college negli Stati Uniti. Provavo un’attrazione insaziabile per la storia contemporanea austriaca e tedesca, e mi riproponevo di diventare uno storico. Mi sforzavo per comprendere il contesto politico e culturale in cui si erano svolti questi eventi drammatici, il modo in cui un popolo amante dell’arte e della musica potesse di punto in bianco commettere gli atti più barbarici e crudeli. Scrissi molte tesine di fine trimestre sulla storia austriaca e tedesca, compresa una tesi di ricerca sulle reazioni degli scrittori tedeschi all’ascesa del nazismo.
Poi, all’ultimo anno di college, il 1951-1952, mi scoprii attratto dalla psicoanalisi, una disciplina il cui fulcro sta nel sollevare a uno a uno gli strati della memoria e dell’esperienza personale per capire le radici, spesso irrazionali, delle motivazioni, dei pensieri e dei comportamenti umani. Nei primi anni Cinquanta, coloro che praticavano la professione di psicoanalisti erano per la maggior parte anche medici. Decisi quindi di iscrivermi alla facoltà di medicina, dove fui testimone della rivoluzione in atto nella biologia, di fronte all’eve- nienza sempre più verosimile che i misteri fondamentali della natura delle cose viventi stessero per essere svelati. Meno di un anno dopo l’inizio dei miei studi di medicina, nel 1952, veniva scoperta la struttura del DNA. Come conseguenza di ciò, iniziò a schiudersi all’esame della scienza il funzionamento genetico e molecolare della cellula. Con il tempo, quelle ricerche si sarebbero estese alle cellule che costituiscono il cervello umano, l’organo più complesso dell’universo. Fu allora che presi in considerazione l’idea di esplorare il mistero dell’apprendimento e della memoria in termini biologici. In che modo il mio passato viennese aveva lasciato tracce durevoli nelle cellule nervose del mio cervello? Secondo quale trama il complesso spazio tridimensionale dell’appartamento dove guidavo la mia automobilina si era insinuato nella rappresentazione interna al mio cervello dello spazio intorno a me? In che modo il terrore ha impresso i colpi alla porta di casa come cicatrici nel tessuto molecolare e cellulare del mio cervello, con inalterabilità tale da consentirmi di rivivere l’esperienza nei suoi più vividi dettagli visivi ed emotivi più di cinquant’anni dopo? Domande come queste, che fino a una generazione fa restavano senza risposta, stanno per dischiudersi alla nuova biologia della mente. La rivoluzione che catturò la mia immaginazione di studente di medicina ha trasformato la biologia, dal campo largamente descrit- tivo che era, in una scienza coerente con solide basi nella genetica e nella biochimica. Prima dell’avvento della biologia molecolare, erano prevalenti tre idee separate: l’evoluzione darwiniana, l’idea cioè che gli esseri umani e gli altri animali si fossero gradualmente evo- luti da progenitori animali più semplici alquanto differenti da loro; la base genetica dell’ereditarietà dell’aspetto fisico e delle caratteristiche mentali; la teoria che la cellula sia l’unità di base di tutte le cose viventi. La biologia molecolare ha riunito queste tre idee met- tendo a fuoco le azioni di geni e proteine nelle singole cellule. Ha ravvisato nel gene l’unità che determina l’eredità, la forza che guida il cambiamento evolutivo, e ha individuato i prodotti del gene, le proteine, come gli artefici della funzionalità cellulare. Per mezzo dell’esame degli elementi fondamentali dei processi vitali, la biologia molecolare ha rivelato ciò che tutte le forme di vita hanno in comune. Ancora più della meccanica quantistica o della cosmologia, gli altri campi della scienza che nel XX secolo sono stati investiti da una rivoluzione di ampia portata, la biologia molecolare si impone alla nostra attenzione in quanto influenza direttamente le nostre esistenze quotidiane. Va al cuore della nostra identità, del chi noi siamo. La nuova biologia della mente si è sviluppata per gradi nel corso dei cinque decenni della mia carriera. I primi passi risalgono agli anni Sessanta, quando la filosofia della mente, la psicologia comportamentale e la psicologia cognitiva (lo studio dei fenomeni mentali complessi nelle persone) si sono fuse, dando origine alla psicologia cognitiva moderna. Questa nuova disciplina tentò di trovare elementi comuni nei processi mentali complessi di vari animali, dai topi alle scimmie, agli esseri umani. Un approccio che in seguito fu esteso ad animali invertebrati più semplici, come lumache, api e moscerini. La psicologia cognitiva moderna era a un tempo rigorosa dal punto di vista sperimentale e dotata di ampie basi teoriche. Prendeva in esame una gamma di comportamenti, dai riflessi semplici in animali invertebra- ti ai più elevati processi mentali delle persone, come la natura dell’attenzione, della coscienza e del libero arbitrio, per tradizione appartenenti all’ambito della psicoanalisi. Negli anni Settanta la psicologia cognitiva, la scienza della mente, si fuse con la neuroscienza, la scienza del cervello. Il risultato furono le neuroscienze cognitive, una disciplina che introdusse nella psicologia cognitiva moderna i metodi biologici di indagine dei processi mentali. Negli anni Ottanta la neuroscienza cognitiva fruì di un enorme impulso grazie all’imaging cerebrale, una tecnologia che permise agli studiosi del cervello di realizzare il loro sogno, scrutare cioè all’interno del cervello umano e osservare l’attività di svariate sue regioni mentre un individuo svolge le più sofisticate funzioni mentali, come percepire un’immagine visiva, pensare a un percorso spaziale, o dare inizio a un’azione volontaria. L’imaging cerebrale opera per mezzo di indici che misurano l’attività neurale: la tomo- grafia a emissione di positroni (PET) rileva il consumo di energia del cervello, e l’imaging a risonanza magnetica funzionale (fMRI) ne rileva l’utilizzo di ossigeno. Nei primi anni Ottanta le neuroscienze cognitive hanno incorporato la biologia molecolare, dando esito a una nuova scienza della mente – una biologia molecolare delle attività cognitive – che ci ha consentito di esplorare a livello molecolare processi mentali quali il modo in cui pensiamo, proviamo sensazioni, apprendiamo e ricordiamo.
Tutte le rivoluzioni hanno le proprie origini nel passato, e la rivoluzione culminata nella nuova scienza della mente non fa eccezione. Sebbene il ruolo centrale della biologia nello studio dei processi mentali fosse inedito, la capacità della biologia di influenzare il modo in cui vediamo noi stessi non lo era affatto. A metà del XIX secolo, Charles Darwin affermò che non siamo frutto di una creazione a sé stante, bensì di una graduale evoluzione a partire da progenitori animali inferiori; sostenne inoltre che si possono far risalire le tracce dell’intera esistenza fino a un comune antenato: tutto il percorso a ritroso fino alla creazione della vita stessa. Avanzò l’idea ancora più audace che la forza guida dell’evoluzione non è un disegno consapevole, intelligente o divino, ma un processo “cieco” di selezione naturale, un processo di selezione totalmente meccanicistico di ten- tativi ed errori accidentali basato sulle variazioni ereditarie. Le idee di Darwin lanciarono una sfida diretta alle dottrine di quasi tutte le religioni. Dato che l’intento originario della biologia era stato quello di spiegare il disegno divino della natura, queste sue idee recisero il legame storico fra religione e biologia. In ultimo, la biologia moderna ci avrebbe richiesto di credere che gli esseri umani, in tutta la loro bellezza e infinita varietà, non sono altro che i prodotti di combinazioni sempre nuove di basi nucleotidiche, i mattoni di costruzione del codice genetico del DNA. Combinazioni che sono state selezionate nel corso di milioni di anni dalla lotta degli organismi per la sopravvivenza e il successo riproduttivo. La nuova biologia della mente ha un potenziale ulteriormente disturbante in quanto propone che non solo il corpo, ma anche la mente e le specifiche molecole che determinano i nostri processi mentali più elevati – la coscienza del sé e degli altri, la consapevolezza del passato e del futuro – si sono evolute dai nostri progenitori animali. Per di più, la nuova biologia presuppone che la coscienza sia una processo biologico che alla fine potrà essere spiegato in termini di vie di segnalazione molecolare utilizzate da popolazioni di cellule nervose in comunicazione fra loro.
La maggior parte di noi accetta tranquillamente gli esiti della ricerca scientifica sperimentale quando valgono per altre parti del corpo: ad esempio, siamo del tutto a nostro agio con il fatto che il cuore non è la sede delle emozioni, ma un organo muscolare che pompa sangue attraverso il sistema circolatorio. Eppure l’idea che la mente e la spiritualità umane si originino in un organo fisico, il cervello, per alcuni suona nuova e allarmante. Costoro trovano difficile credere che il cervello sia un organo computazionale che elabora informazioni, la cui meravigliosa potenza non deriva dal suo mistero, bensì dalla sua complessità: dall’enorme quantità, varietà e interazione delle sue cellule nervose. Per i biologi che studiano il cervello, quando si applicano metodi sperimentali al comportamento umano, la mente non perde nulla della sua bellezza o del suo potere. Analogamente, i biologi non temono che la mente possa essere resa insignificante da un’analisi riduzionista, che delinea le parti componenti e le attività del cervello. Al contrario, la maggioranza degli scienziati è convinta che l’analisi biologica possa accrescere il nostro rispetto per la potenza e la complessità della mente. In effetti, avendo unificato la psicologia cognitiva e comportamentale, la neuroscienza e la biologia molecolare, la nuova scienza della mente può affrontare questioni filosofiche con le quali i massimi pensatori hanno lottato per millenni: in che modo la mente acquisisce la conoscenza del mondo? Quanta parte della mente è ereditata? Le funzioni mentali innate ci impongono un modo prefissato di acquisire esperienza del mondo? Quali modificazioni fisiche si verificano nel cervello quando apprendiamo e ricordiamo? In che modo un’esperienza di pochi minuti si converte in un ricordo che dura per tutta la vita? Domande di questo tipo non appartengono più al dominio delle speculazioni metafisiche, ma sono ora terreni fertili della ricerca sperimentale.
Le intuizioni fornite dalla nuova scienza della mente assumono maggiore pregnanza quando analizzate rispetto alla comprensione dei meccanismi molecolari che il cervello impiega per immagazzinare i ricordi. La memoria – la capacità di acquisire e immagazzinare informazioni, che siano semplici come i dettagli della routine giornaliera o complesse come la conoscenza astratta della geografia e dell’algebra – è uno degli aspetti più notevoli del comportamento umano. Ci consente di risolvere i problemi che affrontiamo nella vita di tutti i giorni schierando contemporaneamente numerosi fattori, un’abilità vitale per la risoluzione dei problemi. In un senso più esteso, la memoria garantisce la continuità della nostra vita. Ci fornisce un quadro coerente del passato che colloca in prospettiva le esperienze in corso, un quadro che può non essere razionale o accurato, ma che comunque permane. Senza la forza agglomerante della memoria, le esperienze sarebbero scisse in tanti frammenti quanti sono i momenti della vita. Senza la possibilità di compiere viaggi mentali nel tempo, conferita dalla memoria, non avremmo consapevolezza della nostra storia personale, né modo alcuno di ricordare le gioie che fungono da nette pietre miliari della nostra esistenza. Siamo quelli che siamo per via di ciò che impariamo e di ciò che ricordiamo. I nostri processi mnemonici ci sono di ulteriore giovamento per il fatto che ci permettono di ricordare agevolmente gli eventi felici e diluire l’impatto emotivo di fatti traumatici e dolorosi. Ma a volte, vi sono memorie di orrori che persistono e danneggiano le vite delle persone, come accade nei disordini da stress post-traumatico, una condizione di cui soffrono molti di coloro che hanno sperimentato in prima persona le terribili vicende dell’Olocausto, oppure guerre, rapimenti e disastri naturali. La memoria è essenziale non solo per la continuità dell’identità individuale, ma anche per la trasmissione della cultura e per l’evoluzione e la continuità delle società nel corso dei secoli. Anche se da quando l’Homo sapiens ha fatto la sua prima comparsa nell’Africa orientale, circa 150.000 anni fa, le dimensioni del cervello non sono cambiate, la capacità di apprendimento dei singoli esseri umani e la loro memoria storica sono cresciute lungo i secoli per mezzo dell’apprendimento condiviso, vale a dire attraverso la trasmissione della cultura. L’evoluzione culturale, una modalità di adattamento non biologica, agisce in parallelo all’evoluzione biologica come mezzo per trasmettere la conoscenza del passato e i comportamenti adattivi attraverso le generazioni. Tutti i conseguimenti dell’umanità, dall’antichità fino a oggi, sono i prodotti di una memoria condivisa accumulata nel corso dei secoli, per il tramite sia di registrazioni scritte sia di una tradizione orale salvaguardata con cura. Come la memoria condivisa arricchisce le nostre vite a livello individuale, così la perdita di memoria distrugge il nostro senso del sé. Recide la connessione con il passato e con le altre persone, e può manifestarsi durante lo sviluppo infantile oppure colpire un adulto in età matura. La sindrome di Down, il morbo di Alzheimer e la perdita di memoria correlata all’età avanzata sono esempi ben noti delle molte malattie che danneggiano la memoria. Oggi sappiamo che i disturbi della memoria contribuiscono anche all’insorgenza di disordini psichiatrici: la schizofrenia, la depressione e gli stati d’ansia portano con sé l’aggravante di una funzionalità mnemonica difettiva. La nuova scienza della mente reca la speranza che una maggiore comprensione della biologia della memoria possa condurre a cure più efficaci sia per la perdita di memoria sia per i ricordi dolorosi persistenti. In effetti la nuova scienza avrà probabilmente delle rica- dute pratiche su molte aree connesse alla salute, pur non limitandosi di certo alla ricerca di soluzioni per malattie devastanti: essa mira infatti a penetrare il mistero della coscienza, compreso il suo mistero ultimo, cioè il modo in cui il cervello di ogni persona crea la consapevolezza di un sé unico e ne determina la libera volontà.